Storia della sanità, capitolo XXIV: la farmacopea nella Roma imperiale
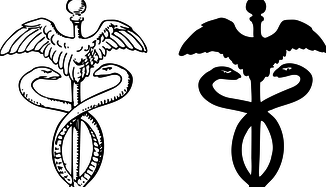
di Emanuele Davide Ruffino
e Germana Zollesi |
La natura pratica dei romani aiutò a volgere l’attenzione ad una scienza concreta come la farmacologia: la somministrazione di sostanze ha da sempre esercitato un certo effetto placebo e ha permesso di sviluppare, fin dall’antichità, un mercato di notevole rilievo. Per i Romani dei primi secoli, gli ingredienti base erano soprattutto la salvia, il rosmarino, la cicoria e la malva: ma ben presto dal porto di Olbia e dai mercati della penisola, si è fatto arrivare nell’Urbe tutto ciò cui si riusciva ad attribuire una qualche potenzialità taumaturgica.
Come per tutte le società opulente, il fascino del preparato miracoloso, specie se proveniente da fantastici, esotici e misteriosi luoghi lontanissimi, assumeva un particolare fascino. Infatti, le legioni romane e i maestri del diritto potevano conquistare il mondo, ma non riuscivano a proteggere Roma dall’assalto dei venditori di farmaci. L’aurea di mistero che doveva necessariamente accompagnare questi preparati ha fatto sì che diventa oggi difficile risalire alla loro composizione. L’abitudine di preparare dei medicinali con molte sostanze nacque sia dalla necessità di accrescere il richiamo verso il preparato, sia di renderlo difficilmente replicabile. Sotto un profilo clinico invece è tutto da dimostrare che più un medicamento fosse preparato con più sostanze, maggiore fosse la sua potenzialità terapeutica. Ma un miscuglio di prodotti rendeva difficile l’imitazione: non essendoci ancora le royalties sui farmaci, l’unico modo era quello di renderli incomprensibili ai più, in modo da mantenere le conoscenze farmacologiche in mano a pochi addetti.
Dalla Grecia a Roma fiorisce il commercio dei farmaciConsiderato il giro d’affari che gravitava intorno a questi preparati, per contrastare il fascino del prodotto esotico, spesso furono gli stessi medici a preparare i farmaci, avendo sempre cura di aggiungere odori forti e raggiungere una colorazione particolarmente vivace, per creare un effetto scenico, oltre il tradizionale effetto placebo. Non erano farmacisti, ma qualche concetto di marketing dovevano già averlo acquisito: vincendo su Cartagine avevano, infatti, intuito il giro d’affari che i Fenici erano riusciti ad attivare commerciando preparati farmacologici (o presunti tali). Per anni, i Fenici, detennero il commercio delle droghe in tutto il mar Mediterraneo. A contrastare questo furono i greci con i cosiddetti “iatra”, botteghe con un’ampia porta in cui si poteva vedere il medico farmacista preparare il prodotto. La gelosia con cui si preparavano quei farmaci fece sì che non si riuscì a separare, in quell’epoca, la professione del medico da quella del farmacista, ma le due arti risiedevano in capo alla stessa persona e non si riuscì ad instaurare commerci su larga scala. I romani presero il meglio delle due tradizioni, anzi sfruttarono la concorrenza tra i farmaci fatti in loco davanti al paziente (con un po’ di cerimoniale che non guasta mai), con quelli provenienti dalle località più strane: in entrambi i casi, l’effetto placebo era garantito.
Mode farmacologiche già in voga nell’UrbeIl più curioso dei farmaci di cui si ha memoria fu un micidiale miscuglio, elaborato da Mitridate: la Teriaca (dal greco Therion, vipera), un miscuglio di 62 sostanze, dall’asfalto alla cannella, dalla gomma arabica alla trementina, mescolate a parti di vipera tritate che veniva ingerito dopo essere stato lungamente bollito. Cosa dovesse curare quest’intruglio era a discrezione del prescrittore, ma per fortuna, l’idea del cerimoniale, incentrato sulla cottura prolungata, evitò infauste conseguenze. Grazie alla ricchezza della Repubblica, nell’Urbe veniva importato, da tutto il mondo conosciuto, tutto ciò di cui si narrava potesse servire per la cura delle persone. E grazie alle conquiste militari, Roma era diventata il terminale di ogni conoscenza e di ogni prodotto, compresi gli amuleti, i preparati taumaturgici e la disperata voglia di guarire dei patrizi romani faceva sì che tutto potesse sembrare miracoloso. Una sostanza base era facilmente imitabile: ma gli abili commercianti, erano bravissimi a proporre sempre nuovi intrugli composti dalle sostanze più strane, contenute in scrigni dalle forme più strane e da somministrarsi solo in determinati giorni od ore del giorno e pronunciando appropriati riti propiziatori. Se poi il tutto veniva erogato da un professionista, aumentava di credibilità.
Le prime pratiche chirurgiche con antidolorifici e sedativiI medici romani avevano a disposizione un’ampia gamma di antidolorifici e sedativi, a cominciare dagli estratti del papavero da oppio, dai semi di giusquiamo (scopolamina), dallo stramonio e dalla radice di mandragola: tutte piante facenti parte della famiglia botanica delle Solanacee. L’uso del papavero è assai antico: la prima prova documentata è data dal diadema di capsule di papavero di Amanita Muscaria, una divinità cretese, venerata tra il 1400-1200 a.C. ma resti fossili di semi e di capsule di papavero da oppio, si ritrovano già nel Neolitico e all’Antica Età del Bronzo sia in Europa che in Asia. Diverse erano le modalità di somministrazione di queste sostanze: finemente triturate o ridotte in polvere o estratte come tintura, erano inalate oppure ingerite, disciolte in vino, aceto, latte od olio, miele o grasso, oppure sotto forma di pillole, o d’infuso e decotto. Erano somministrate, singolarmente o più spesso mescolate in varia composizione tra loro, secondo dosaggi prestabiliti. Le conoscenze degli effetti prodotti da queste sostanze permise ai chirurghi romani di praticare le prime anestesie, soppiantando la pratica di far tenere fermo il paziente dagli assistenti, mentre si procedeva all’intervento. La possibilità d’indurre il sonno e quindi poter operare su un corpo che non si dimenava rappresentò un grande passaggio nella storia della chirurgia: il problema era semmai quello di riuscire a mantenere il paziente incosciente per, tutta e solo, la durata dell’operazione…
Le droghe utilizzate per i condannati a morteSeneca, nel riferire su come operavano i chirurghi “quando operano le ossa o infilano le mani nelle profondità degli intestini”, li paragona espressamente ai peggiori crolli o incendi. Va però dato atto al filosofo che fu lui forse il primo a sancire il principio della non discriminazione del malato (Sen., De Clem.,XXVIII,4): Quaedam in medio ponuntur: tam bonis quam malis conduntur urbes […] medicina etiam sceleratis opem monstrat; compositiones remediorum salutarium nemo suppressit (Alcuni beni sono in comune; le città vengono costruite per i buoni come per i cattivi […] la scienza medica fornisce il suo aiuto anche agli scellerati; nessuno può sospendere la fabbricazione di un santuario della medicina solo perché questo potrebbe permettere di guarire anche chi non lo merita). In particolare, le sostanze maggiormente utilizzate erano il papavero da oppio, la cannabis, le foglie e il succo di giusquiamo, lo stramonio, la mandragora, le foglie d’alloro. Discorso a parte merita la spongia somnifera (spugna sonnifera), usata sicuramente anche come farmaco, ma diventata famosa perché somministrata ai condannati a morte per crocifissione; per questo era anche conosciuta con il nome di morion o vino della morte, dal momento che l’inalazione dei suoi vapori misti all’aceto o l’assunzione di vino alla mandragora, in cui talvolta era imbevuta, provocava nei condannati uno stato di morte apparente, talché i centurioni preposti alle esecuzioni avevano l’ordine di bucare il loro corpo con la lancia, prima di dichiararne la morte.
Posted on: 2020/12/11, by : admin

