Degrado del linguaggio, deriva del Paese
Nel Bel Paese il pensiero sembra ormai diventato un elemento semiclandestino della vita politica, da coltivare in stanze remote, come carbonari dell’Ot- tocento. Almeno è questa l’impressione che si ricava dai primi sette mesi di governo gialloverde congestionato da messaggi entusiastici, annunci e promesse mirabolanti, in cui il trionfalismo per ciò che verrà è direttamente proporzionale alla decadenza del linguaggio. Un impoverimento diventato norma, anziché eccezione, più che riprovevole. Non stupiamoci. A quest’aporia comportamentale si è arrivati per gradi. Il noto principio della rana bollita, utilizzato dal novantenne Noam Chomsky, uno dei più grandi pensatori viventi, autentica coscienza critica dell’America, spiega con efficacia la deriva in cui precipita una società che progressivamente espunge per passività e indolenza i suoi valori etici e morali con gravi ripercussioni sullo stato di salute della sua democrazia. Ora, che l’Italia si ritrovi nella stessa condizione della rana immersa in una pentola d’acqua riscaldata a fuoco lento è fuori di dubbio. Rimane soltanto da sperare che la temperatura non abbia raggiunto il livello di precottura e augurarsi che sappia esibirsi in un salto acrobatico per ricucire i fili smagliati della democrazia. In alternativa, ci si può affidare o a madre natura o ai miracoli, consapevoli che gli effetti collaterali potrebbero risultare anche pericolosi: chi è pieno di rancore non sempre ha la lucidità per non svendere la democrazia. Osservando ciò che succede in tante parti del mondo, l’effetto è da mettere in conto.
Il tempo non gioca però a favore del nostro Paese. Gli ultimi fenomeni della politica (in Italia come in Europa e in altri continenti) “populismo” e “sovranismo” in ordine di apparizione, si sono arrampicati come l’edera sui muri scrostati di un sistema sordo e irragionevolmente portato a credere di mantenere lo status quo con la stessa demagogia che oggi si rimprovera a chi comanda oggi. Si concorda che le parole hanno perduto peso specifico e serietà nel quotidiano come nella politica. Si dimentica però di aggiungere (forse per carità di patria) che la degenerazione è avvenuta sotto l’occhio complice di chi l’ha negata, di chi non ha saputo preventivamente correre ai ripari, di chi si è illuso di eternizzare la società, secondo schemi immutabili, in nome di un ordinario conformismo, vilmente per attendismo, mentre i cambiamenti procedevano veloci e gli effetti diventavano a loro volta cause, in un corto circuito perverso. Se è l’uso che sviluppa l’organo, cioè il pensiero, non è improbabile che lo stesso sia portato ad agire in maniera distorta e deteriore all’interno di una società narcotizzata. In passato non era infrequente preoccuparsi di quel fenomeno definito “analfabetismo di ritorno”. Sic stantibus rebus, il fenomeno è sulla soglia di un poco edificante “analfabetismo di sola andata”… E lo stato della scuola, che ha subito continui tagli al bilancio e profondi tagli all’autorevolezza del corpo insegnante, mal pagato e tutelato, è una spia tutt’altro che secondaria del malessere sociale, non induce all’ottimismo. Se crolla il ruolo della scuola pubblica nel nostro Paese (le scuole, inve- ce, intese come manufatto, purtroppo crollano da tempo e provocano morti e feriti), a ruota crollerà anche l’impalcatura dei valori morali ed etici che essa ha saputo trasmettere di generazione in generazione. Difesa dell’esistenza di una Costituzione democratica, fondata sul lavoro, in primis.
Il degrado di una società si misura anche della svalutazione in cui precipitano le parole e dalla disattenzione che poniamo alla loro potenza nel ferire, se non a uccidere, come ha ammonito papa Francesco nella sua catechesi del 17 ottobre. L’insulto uccide ha detto il Pontefice, citando un brano del Vangelo, che si richiama alla rivelazione di Gesù Cristo: anche l’ira contro un fratello è una forma di omicidio. Ma Gesù non si ferma a questo, prosegue papa Francesco: “nella stessa logica aggiunge che anche l’insulto e il disprezzo possono uccidere. E noi siamo abituati a insultare, è vero. E ci viene un insulto come se fosse un respiro”. Minacce, ironie sul filo del dileggio, offese, insulti, sono i veri padroni di casa del linguaggio quotidiano e politico, privato e pubblico, che da decenni alimentano un vasto repertorio di battute, di autoreferenzialità estreme con iperboliche attribuzioni di capacità, di bravura sotto l’egida di una ricchezza di soluzioni impossibili con cui narcotizzare i cittadini, le rane della pentola. Silvio Berlusconi, dalla sua discesa in campo nel 1993, è colui che prima di ogni altro ha concimato quel terreno arato con certosina pazienza: proverbiali le sue barzellette per accorciare metafisicamente le distanze tra Potere e Popolo, alternate a sostantivi gettati come fango sugli avversari politici (“comunista!, comunista!”) in un perfido gioco da poliziotto buono e poliziotto cattivo. Per non parlare del “Contratto con gli italiani”, artificio de- magogico fuori dalla Carta costituzionale, che ha trovato in Di Maio e Salvini i suoi degni epigoni con il “Contratto di governo” siglato nel maggio scorso dai due, in nome del Movimento cinque stelle e Lega. Un salto (che sconsi- gliamo alla rana) nel passato lugubre della famosa massima attribuita a Mussolini “È l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende”. Del resto, la coppia Di Maio-Salvini (77 anni in due) sembra più predisposta, anche per naturali vantaggi anagrafici (come lo è stato per Matteo Renzi), ad approfittare di un’energia giovanile, che neppure Berlusconi possedeva all’apice del suo potere (58 anni), per imporre una visione muscolare nei rapporti con le piazze (l’una del Movimento, l’altra della Lega) indifferente alle esigenze della democrazia che impone una fatica quotidiana e un giudizio costante per essere pienamente realizzata e praticabile.
La lingua universale delle emozioni
Non deve sorprendere dunque se una parte dei cittadini non si riconosce più in questo Paese, e non solo per ragioni d’età o perché le piazze tendono a moltiplicarsi e a spuntare come funghi, utilizzando tutta la gamma dei colori dell’iride, che non rispondono più né nella domanda, né nella protesta, a quelli tradizionali. I colori nella loro diversità non riflettono però idee o ideologie, come nel passato, ma emozioni espresse da una  babele di lingue, tutte mal parlate e, quel che peggio, che nessuna parte vuole imparare dalle altre. In fondo, la lingua universale delle emozioni può fare a meno di grammati- che, sintassi, semantiche, costruzioni logiche e del periodo. Le emozioni si veicolano anche con il corporeo, il movimento della testa o degli arti, con lo sguardo, con la sillabazione sincopata: sì, no, le sillabe più à la page nell’attuale politica (le meno indicate dai filosofi), che offrono le migliori e rapide opportunità di cambiamento di casacca e di campo, senza spiegazioni.
babele di lingue, tutte mal parlate e, quel che peggio, che nessuna parte vuole imparare dalle altre. In fondo, la lingua universale delle emozioni può fare a meno di grammati- che, sintassi, semantiche, costruzioni logiche e del periodo. Le emozioni si veicolano anche con il corporeo, il movimento della testa o degli arti, con lo sguardo, con la sillabazione sincopata: sì, no, le sillabe più à la page nell’attuale politica (le meno indicate dai filosofi), che offrono le migliori e rapide opportunità di cambiamento di casacca e di campo, senza spiegazioni.
Del resto, di emozioni si può parlare in tanti modi. Allo stesso modo si pos- sono sperimentare e vivere in modi diversi: a un estremo vi sono le emozioni non pensate e agite in modo spontaneo, talvolta persino violento, senza alcu- na elaborazione interna con l’effetto di far sentire colui che le vive padrone del suo mondo e giudice di ogni situazione che impatta sulla sua persona; all’estremo opposto le emozioni pensate espressione di legami tra vissuti interni alla persona e letture inerenti alla propria vita e al mondo circostante nel rispetto di una socialità condivisa e rispettata. Il linguaggio nella sua accezione più nobile ha a che fare con la possibilità di intercettare i nostri pensieri (i pensieri di ognuno), nel loro intreccio tra emozioni e cognizioni e di rivolgerli e condividerli con un sociale che, se in grado di recepirli e pensarli, sarà in grado di diventare volano di una visione culturale comunitaria. Una visione cioè non orientata alla creazione di leader bensì alla creazione di pensieri condivisibili poiché ci si è concesso il tempo necessario a sedimentarli per renderli trasformativi in più passaggi di confronto.
All’opposto, le emozioni, seppur importanti quando coniugate con il pen- siero, tendono a penalizzare quest’ultimo se il mezzo di condivisione è un linguaggio unicamente emozionale, impoverito nel suo portato comunicativo. Questo spiega perché la povertà del linguaggio si presta ad avvicinare le mas- se nei momenti in cui queste per un maggiore bisogno di rassicurazione (nelle crisi e nei cambiamenti accelerati sul piano sociale) sono suggestionabili da frasi dirette, che semplificano la lettura della realtà e parlano direttamente alla pancia e alle emozioni, senza compromesso alcuno con l’intelletto. Com- promesso – qualora ve ne fosse bisogno di ricordarlo – che rimane il valore aggiunto di ogni democrazia. “Quanto più insistente è la critica – scriveva Hans Kelsen, uno dei più grandi giuristi degli anni Trenta, studioso della Re- pubblica di Weimar – quanto più consapevole dei propri fini l’opposizione della minoranza, tanto più i deliberati della maggioranza acquistano il carat- tere di compromessi (in corsivo nel testo N.d.A), e il compromesso è appunto ciò che caratterizza la politica della democrazia”. Lontani anni luce, dunque, dalle passate e continue lamentazioni di Berlusconi, trasformatesi in un este- nuante ritornello all’insegna di “Non mi fanno lavorare” rivolto al Paese da ogni pulpito. Esternazioni che hanno catturato nel passato e di recente anche Renzi, in particolare in chiave interna al Pd. Ma l’unico capace di riproporre con freschezza e frequenza martellante le esternazioni su più piani e a gio- carle con disinvoltura e spregiudicatezza a 360 gradi è sicuramente Matteo Salvini. Inimitabile. Un paio di esempi ancora vivi sono sufficienti a rendere l’idea di come vada all’attacco il leader della Lega. A metà ottobre, sbotta coi magistrati, sempre sulla vicenda della nave Diciotti: “Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare”; ad inizio dicembre apostrofa gli imprenditori, poco teneri con le misure adottate dal governo a favore dell’occupazione, con un brusco “lasciatemi lavorare, voi zitti per anni”. Insomma, un’invocazione che tende a raccogliere il comune sentire di chi esplicitamente o intimamente per interesse, educazione, cultura, ritiene che il confronto sia disturbante. L’esatto opposto delle regole democratiche.
Eppure le stesse frasi lette e rilette sui giornali finiscono per diventare colore, se non addirittura patrimonio folcloristico del personaggio Salvini. Ma se per un attimo si fuoriesce da questa rappresentazione per così dire buonista, allora appare evidente che a monte c’è la volontà di ridimensionare l’avversario, di proiettare all’esterno in maniera incontrovertibile ordini di grandezza a lui sempre favorevoli e da usare su più tavoli per l’opinione pubblica. L’atteg-giamento verboso e platealmente iroso praticato con mondo confindustriale, per esempio, non si è limitato a colpire una parte sociale, ma indirettamente ha spiazzato anche chi il mondo del lavoro lo rappresenta a titolo istituzio- nale, cioè il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, già costretto a giocare di rimessa a causa del noto “infortunio” familiare: la denuncia di lavoro “in nero” consumatosi nell’azienda di suo padre. Disavventura antica riaffiorata dal pedigree famigliare che ha tolto per qualche giorno il sorriso dal volto di Di Maio junior, e raffreddato gli aut aut a colleghi di governo tiepidi, come il ministro dell’Economia Giovanni Tria, sul reddito di cittadinanza. Proverbiale la sua sfuriata, a metà settembre, con allegato invito al titolare del dicastero economico di togliere il disturbo. Episodi a getto continuo che i media hanno registrato sul fronte grillino quasi per inerzia, in assenza di argomenti seri che non fossero le polemiche con l’Ue sul bilancio.
Lo scontro con l’Unione Europea
Il braccio di ferro sulla manovra economica con i commissari di Bruxelles su frazioni di percentuali si è rivelato una sorta di cartina di tornasole per comprendere quale sia il concetto di democrazia inalato dalla diarchia che governa l’Italia. Una trattativa che paradossalmente si è sbloccata, dopo mesi di tuoni e fulmini contro la procedura d’infrazione ventilata dall’Ue, di sor- tite muscolari di Salvini – tra le tante “L’Europa può mandare anche Padre Pio, ma io la legge Fornero la smonto pezzo per pezzo” – con la decisione di mandare avanti ad inizio il presidente del Consiglio Conte, non ancora bruciato con Juncker e Moscovici, e dunque con tutte le carte in regola per aprire un dialogo costruttivo, peraltro intavolato ufficiosamente da palazzo Chigi nel G20 di Buenos Aires sulla base di un deficit al 2 per cento. Luci di scena traslocate momentaneamente sulla figura di Conte, anche se a martedì 18 dicembre, il barometro sui conti non dà segnali di bonaccia, con l’Europa che continua a tenere sotto scacco Roma con la procedura di infrazione che penzola come una spada di Damocle. Spada impugnata dai tecnici della Com- missione europea che indagano su quei numeri mai del tutto illuminati dalle garanzie avanzate dell’Italia. Eppure, settimane fa l’esecutivo non si era trat- tenuto dall’ennesimo e roboante annuncio sulla manovra economica definita “dirompente” e in grado di evitare la terza recessione ventilata sulla base dei dati Istat, sebbene lo spread abbia bruciato una fetta rilevante della ricchezza del Paese che nel terzo trimestre dell’anno ha marciato su se stesso, con il Pil fermo sullo zero, mentre l’asta dei titoli di Stato ha subito una brusca impennata del rendimento (3,25 per cento) per essere accolta dagli investitori, allertati dai maggiori rischi che corre l’azienda Italia. Effetto costoso, se si getta un’occhiata alle spalle, ai giorni d’estate, del marcamento a uomo del Movimento cinque stelle sul ministro Tri nella vana speranza di convincere il dicastero economico a mantenere il deficit sul 2,9 per cento. Un miraggio incompatibile con la prova di serietà che ci chiedeva in quel frangente l’Europa e i mercati finanziari, pagato salato. Un prezzo su cui è calato e conti- nua a calare il silenzio, oscurato da successi “parolai” incompatibili con la realtà tratteggiata dall’Istat: 1) aumento della disoccupazione, 2) calo della domanda interna, 3) riduzione del fatturato delle industrie. Un triangolo nero che non è un buon viatico per superare le riserve della Commissione Europea indisponibile ad accettare il Documento programmatico di Bilancio (DPB) come l’ennesimo libro dei sogni, non dissimile da quelli presentati da Mattei Renzi nel 2016 e nel 2017, fondati su entrate di privatizzazioni, mai realizzate pienamente. Eppure, quando il ministro Savona ha provato ancora di recente a dare serietà alle affermazioni dell’esecutivo, ammettendo che “la situazione del Paese è grave”, Salvini lo ha letteralmente placcato e come infilato in una camicia di forza per ascoltare le sue sicurezze: “Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per gli italiani, quindi io sono convinto di fare ciò che è bene per l’Italia. In Europa io non faccio la voce grossa, rivendico il diritto degli italiani ad andare in pensione, lavorare e curarsi”. Promesse encomiabili, ma come si realizzeranno e a spese di chi?
Insulti e dileggio nel confronto politico
Sulla scena politica dell’Italia Repubblicana l’insulto o il linguaggio focoso a volo radente o in picchiata sul triviale per aggredire, dileggiare, irridere, insultare l’avversario non sono mai stati ospiti indesiderati, sgraditi. Persino un personaggio politico della statura di Palmiro Togliatti, fine intellettuale incline a manifestare la propria superiorità culturale con artisti, filosofi, letterati, cadde tra le braccia della volgarità – se tale si può classificare, considerati i nostri tempi – liquidando il suo avversario politico durante l’accesa – per usare un eufemismo – campagna elettorale al voto del 18 aprile 1948 con una frase rimasta famosa: “Voglio comprarmi un paio di scarponi chiodati per dare un calcio nel sedere a De Gasperi”. Battuta casta che fa giustizia anche delle intemperanze del personaggio televisivo “cintura nera” di turpiloquio: quel Vittorio Sgarbi che esaurite le sue riserve (notevoli) di epiteti, nelle si-tuazioni estreme cerca il rilancio dell’audience con una scarica di “comunista! comunista!” sul malcapitato di turno. E, in effetti, la sortita di Togliatti sembra quasi appartenere di diritto a quel gran canovaccio della commedia politica all’italiana tra comunisti e Democrazia Cristiana che ha avuto il suo eponimo in Giovannino Guareschi, inventore di una proiezione domestica dello scontro Pci-Dc con i suoi eroi, il parroco don Camillo e il sindaco comunista Peppone, acerrimi nemici fuori, nel contrasto quotidiano, quanto vicini nelle traversie intime e personali. Un’avversione dunque temperata, più figlia di steccati ideologici, di mondi contrapposti e inconciliabili che dell’idiosincrasia personale, secondo la visione romanzata di Guareschi che nella realtà era comunque un anticomunista viscerale, quanto uomo e scrittore di grande coerenza. Condannato per diffamazione ai danni proprio di Alcide De Gasperi, Guareschi rifiutò di procedere nel giudizio di  appello e di chiedere la grazia. Scontò la sua pena in carcere. Altri tempi, altre tempre rispetto a chi, reiteratamente colpevole, oggi usa ogni sotterfugio per sottrarsi alla pena, non ultimo lo scudo della prescrizione derivato dalla lentezza della giustizia. Ma “l’avversione” esercitata nel passato faceva leva su contenuti comunicativi integrati nel sistema dei partiti politici di massa diversi rispetto ai partiti o movimenti personali odierni. La severa selezione dei quadri dirigenti facilita- va poi una grammatica e un lessico politici aderenti o meno aleatori possibili rispetto al piano di realtà, anche nella rappresentazione della propaganda e delle promesse preelettorali. La serietà e lo stile nell’uso delle parole diventavano così il presupposto fondamentale di una “carriera” che a sua volta diventava garanzia individuale per gli elettori. Non è casuale che i curricula di ieri premiassero l’esperienza professionale e politica nella rappresentan- za istituzionale parlamentare, mentre quelli di oggi danno un’impressione di prêt-à-porter, che a priori esclude la competenza,7 come se questa fosse un fattore di cui vergognarsi. Un processo di svalutazione della competenza che arriva da lontano, cui ha dato involontariamente una forte impronta di legittimazione l’inchiesta Mani pulite (1992) condotta dalla Procura di Milano. Un uragano mediatico e giudiziario che avrebbe incubato per poi partorire nell’immaginario collettivo il primo difensore del Popolo contro le prevaricazioni della Casta (ben prima dell’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte), quell’Antonio Di Pietro, magistrato diventato negli anni successivi capo politico con un suo personale partito (Italia dei Valori). Nel 1994, l’allora cavaliere Silvio Berlusconi, dominus politico di Forza Italia, fu però il primo a concretizzare su scala nazionale, per poi applicare il suo marchio di fabbrica l’anno successivo al voto locale, l’arrembaggio dei “dilettanti” al Parlamento (con largo anticipo sul Movimento Cinque stelle) con cui si sostituiva la competenza con l’assoluta fedeltà al capo.
appello e di chiedere la grazia. Scontò la sua pena in carcere. Altri tempi, altre tempre rispetto a chi, reiteratamente colpevole, oggi usa ogni sotterfugio per sottrarsi alla pena, non ultimo lo scudo della prescrizione derivato dalla lentezza della giustizia. Ma “l’avversione” esercitata nel passato faceva leva su contenuti comunicativi integrati nel sistema dei partiti politici di massa diversi rispetto ai partiti o movimenti personali odierni. La severa selezione dei quadri dirigenti facilita- va poi una grammatica e un lessico politici aderenti o meno aleatori possibili rispetto al piano di realtà, anche nella rappresentazione della propaganda e delle promesse preelettorali. La serietà e lo stile nell’uso delle parole diventavano così il presupposto fondamentale di una “carriera” che a sua volta diventava garanzia individuale per gli elettori. Non è casuale che i curricula di ieri premiassero l’esperienza professionale e politica nella rappresentan- za istituzionale parlamentare, mentre quelli di oggi danno un’impressione di prêt-à-porter, che a priori esclude la competenza,7 come se questa fosse un fattore di cui vergognarsi. Un processo di svalutazione della competenza che arriva da lontano, cui ha dato involontariamente una forte impronta di legittimazione l’inchiesta Mani pulite (1992) condotta dalla Procura di Milano. Un uragano mediatico e giudiziario che avrebbe incubato per poi partorire nell’immaginario collettivo il primo difensore del Popolo contro le prevaricazioni della Casta (ben prima dell’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte), quell’Antonio Di Pietro, magistrato diventato negli anni successivi capo politico con un suo personale partito (Italia dei Valori). Nel 1994, l’allora cavaliere Silvio Berlusconi, dominus politico di Forza Italia, fu però il primo a concretizzare su scala nazionale, per poi applicare il suo marchio di fabbrica l’anno successivo al voto locale, l’arrembaggio dei “dilettanti” al Parlamento (con largo anticipo sul Movimento Cinque stelle) con cui si sostituiva la competenza con l’assoluta fedeltà al capo.
La forza induttiva della televisione
Uno stile che dopo l’uomo di Arcore ha avuto altri e altrettanto bravi, cinici e scaltri epigoni, la cui caratura d’esperienza politica ha dato un altro fiero colpo alla competenza: in ordine d’apparizione sulla scena politica Grillo, Renzi e Salvini. Tutti e tre a loro modo personaggi televisivi.
Il primo, comico di professione, emarginato nella seconda metà degli anni Ottanta dalla Rai per la sua disarmante ironia sulla classe politica (sinceri “vaffa” truccati da battute al vetriolo), in cui ha fatto le prove generali per mandare nell’etere il suo vero proposito: la distruzione in toto delle classi di- rigenti, indipendentemente dall’ideologia, destra, sinistra, centro, indifferente al dopo, al che cosa fare sulle macerie delle istituzioni. Un Conan il barbaro all’italiana Grillo che di recente, in un video postato sul suo blog, con il volto coperto da una maschera, si è riproposto – lui garante del M5S – come coscienza critica del movimento, interrogandosi sui destini della politica nazionale: “Arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo e cosa facciamo […] Non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot”. Domande che lo portano a chiudere il cerchio con una provocazione, assecondando un ritorno alla commedia dell’assurdo: “Grazie a tutti… non ho capito cosa ho detto, ma è lo stesso”. Uscita di scena da guitto che rivela, dietro la maschera ridotta a mimica fissa, la predisposizione a rispondere all’attesa collettiva del Movimento con un nonsense, un luogo comune adatto a tutte le stagioni. Conclusione finalizzata alla conquista (certa) di uno spazio sui media (gli stessi detestati) che farà titolo per non più di 24 ore, prima di trasformarsi in spazzatura mediatica per inceneritore. Un destino, quello dell’autodistruzione di parole inconsistenti elevate all’ennesima potenza dal web, che è la condizione sine qua non per distruggere o spezzettare il pensiero altrui. Operazione che può essere facilitata da e se gli avversari politici, come i personaggi di “Aspettando Godot”, resteranno inanimati, immobili, nella speranza epifanica di un evento che dovrebbe prima o poi modificare i rapporti di forza. Condizione che si è cristallizzata nel Pd, prigioniero dell’idiosincrasia verso il suo stesso partito di Matteo Renzi.
Avanti con le promesse
Del resto, sono proprio i due Matteo, Renzi e Salvini, il prodotto visibile di come si possa beneficiare dell’esperienza estemporanea del mezzo televisivo: concorrenti di quiz sulle reti berlusconiane, passarono poco più che ventenni dall’anonimato alla fama rispondendo a domande banali in due settimane. Una libera docenza in notorietà conquistata sul campo che per effetto transitivo – e con ottimi risultati personali – hanno applicato alla politica nell’era del web, dei social, di un formulario lessicale pervasivo ed efficace in misura direttamente proporzionale alla rapidità, stringatezza e, in alcuni casi, violenza esplicativa delle parole, in una continua sarabanda di un immaginario dialogo a distanza con interlocutori ipotetici da convincere, come in un messaggio commerciale di una merce qualsiasi. E senza preoccuparsi della veridicità o della fattibilità delle cose affermate.
Una tecnica che domina l’attuale governo, in cui il vice presidente del consiglio Luigi Di Maio, leader politico del Movimento cinque Stelle, annuncia il 28 settembre, affacciandosi dal balcone di palazzo Chigi, ostentando braccio e pugno chiuso a mo’ di vittoria raggiunta, che “oggi aboliamo la povertà”, chiaro riferimento all’accordo sul reddito di cittadinanza, rivendi- cazione al primo posto nell’agenda delle promesse dei pentastellati in cam-pagna elettorale. Proposito di per sé auspicabile, quanto apodittico nella sua formulazione all’indicativo del tempo presente del verbo abolire, per- ché non corrisponde minimamente alla sua praticabilità. Si tratta, infatti, dall’accordo sul Def, il documento di economia e finanza, che a distanza di quasi tre mesi non è ancora stato approvato dalla Commissione Europea, come abbiamo ricordato poco sopra. Uno scontro sulle cifre11 che perdura ed ha acceso la polemica verso i valori interni all’unità dell’Europa, in cui l’altro vicepresidente del Consiglio Salvini nel dichiararsi “sovranista” ha promosso fino all’esasperazione il suo hashtag “Gli italiani prima di tutto” e Di Maio si è distinto sottotraccia per qualche punzecchiatura a effetto contro il nemico di turno, attento a non farsi scavalcare nei toni e nelle parole della protesta dal suo omologo leghista. Entrambi, comunque, fermi ai primi di dicembre nello sconfessare Giuseppe Conte sui tempi d’introduzione del reddito di cittadinanza – a marzo 2019 anziché a giugno, secondo il piano delineato dalla presidenza del Consiglio – a dispetto dell’incerta copertura finanziaria e dell’esito negoziale con Bruxelles.
Guardato in uno spazio temporale che va dalla campagna elettorale ad oggi, l’indisposizione a coniugare proposte (promesse) politiche alla realtà è il tratto dominante che accomuna, plasma e cementa il governo gialloverde. Reddito di cittadinanza e riforma del sistema pensionistico (passato nel lessico politico in maniera ingenerosa e spregiativa come Legge Fornero), per esempio, sono stati e sono i pilastri su cui il Movimento cinque stelle e la Lega di Salvini hanno edificato il loro architrave propagandistico. Una sfida alla legge di gravità sul piano finanziario, poiché è quanto di più evidente che sono in antitesi all’esigenza di contenere il debito pubblico che fa dell’Italia l’anatra zoppa dell’Unione europea rispetto alle sue potenzialità sociali ed economiche. È probabile, e se avessimo la sfera di cristallo saremmo pronti a giurarlo, che le due proposte potranno ricevere il segnale di verde dal Commissario europeo per gli affari economici e monetari Jean-Claude Moscovici soltanto a patto di diventare transitorie e non strutturali nel Def. Nulla di straordinario che a quel punto sia Di Maio, sia Salvini, inneggeranno alla vittoria, indisponibili a valutare però i costi/benefici (acronimo ACB) per il Paese di una soluzione transitoria che sottrarrà risorse finanziarie destinabili a investimenti produttivi. Si è citata non a caso l’analisi costi-benefici. L’ACB, infatti, non è mai stata tirata in ballo dal governo, contrariamente al completamento delle opere pubbliche, Tav in primo luogo, nonostante l’impatto non irrilevante sulla manovra di politica economica. Il ritocco all’acceso alle pensioni gode sulla carta di un fondo pari a 6,7 miliardi nel 2019 e a 7 miliardi negli anni seguenti. Numeri che però hanno sollevato obiezioni da più parti, in primis del presidente dell’Inps Tito Boeri, riluttante a credere che i costi del primo anno di applicazione saranno inferiori a quelli successivi. In ogni caso, con la Lega restia a “mettere le mani nelle tasche degli italiani” e il Movimento cinque stelle obbligato a seguirne le orme per non vedersi contestare il reddito di cittadinanza, il ministro Tria dove mai potrà trovare la copertura se non aumentando il debito pubblico? Di cui faranno le spese, naturalmente, nuove generazioni.
L’odio, elemento di coesione
Siamo ancora gli stessi del film del 1964, “Italiani brava gente”? C’è da domandarselo ascoltando il linguaggio di Salvini, che di giorno in giorno tende a inselvatichire le relazioni umane con le sue iniziative contro i migranti e la legge nota come “della sicurezza”, tesa “esclusivamente a rendere sempre più grama la vita degli immigrati, buoni e cattivi, meritevoli e marginali”. O le spiegazioni date alla legge “sulla legittima difesa” pensata come, se vivessimo in un Paese di frontiera, un Far West dove “le pistole dettano legge”, in cui i quartieri periferici e non delle nostre città metropolitane si trasformano al calar della sera in tante sfide all’Ok Corral. Città in cui le persone non esitano a dichiarare di viversi la pistola in casa come “una scappatoia”, una via d’uscita a potenziali aggressioni, tralasciando il rischio di ritrovarsi in casa un’arma che può diventare anche una via d’entrata a reazioni istintive e fuori controllo. O altre che non escludono di essere pronte a sparare “per protegge-re i miei”. Che il Paese non sia più quello di “Italiani brava gente” è scontato. La domanda semmai da porsi è quanto, come e in cosa sia cambiato, rispetto all’epoca in cui Giuseppe De Sanctis, regista di pellicole famose del neorealismo a sfondo sociale, da “Caccia tragica” (1947) e “Riso amaro” (1949) “Non c’è pace tra gli ulivi” (1950), raccontava la storia di un reparto dell’Armir, l’armata che Mussolini mandò nell’estate del 1941 in Unione Sovietica a rafforzare l’esercito di Hitler: un gruppo di soldati che rifiuta la violenza e la prepotenza dei nazisti e che tratta con umanità i prigionieri dell’Armata rossa. Grazie a quel film di un regista comunista , gli italiani hanno vissuto per decenni di rendita (molto tempo prima dell’appiccicoso “buonismo” inventato da Walter Veltroni) su una presunta capacità di umanizzare anche la guerra, che per definizione è disumana, nonostante alcuni precedenti vergognosi.
, gli italiani hanno vissuto per decenni di rendita (molto tempo prima dell’appiccicoso “buonismo” inventato da Walter Veltroni) su una presunta capacità di umanizzare anche la guerra, che per definizione è disumana, nonostante alcuni precedenti vergognosi.
Il dato scientifico proposto di recente dal Censis non lascia margini di interpretazione: l’Italia si è scoperta cattiva. Lo è per ragioni molteplici, com- plesse, note almeno da un decennio, come è stato rilevato anni fa da un acuto osservatore della società italiana. Su tutte campeggia lo stato dell’economia. La disoccupazione generalizzata, a nord come a sud, ha provocato forti crepe nel sentimento di solidarismo, che paradossalmente si era alimentato anche dalla lotta di classe realizzata nelle grandi stagioni sindacali. A ciò si è aggregato, effetto e causa in un corto circuito perverso, l’arretramento dello stato sociale, i tagli al Welfare. La deriva negativa nei giudizi sui migranti che li hanno resi un perfetto capro espiatorio, ad hoc per le nostre fragilità, ha completato il quadro dell’insicurezza sociale. Con il solidarismo ha perduto poi terreno l’influenza della Chiesa cattolica, anch’essa travolta da scandali e oscuri episodi che ne hanno screditato la credibilità non già verso i poveri o gli ultimi, presente grazie allo spirito di migliaia di volontari, quanto verso le nuove fasce di emarginazione sociale aggredite come la società nella sua interezza – ed è l’elemento inedito che ci ritroviamo ad affrontare privi dei giusti anticorpi – da un consumismo imperante, dilagante e diseducativo accettato acriticamente in nome dell’economia di mercato che ha schiacciato la politica e i suoi decisori. Consumismo causa prima di spinte individualistiche irrazionali ed egoismi tossici. Ultimo, ma non meno importante, il permanere di privilegi che sono appannaggio dell’ampia casta di “intoccabili” dimostratasi ampiamente inetta, incapace, corrotta o collusa (politici, alti burocrati di Stato, manager di aziende pubbliche, banchieri) verso i quali i governi prece- denti non hanno mai operato con la deliberata volontà di incidere sul costume attraverso riforme qualificate ed efficaci.
Il Censis glissa (non potrebbe fare altrimenti) sulle responsabilità politiche di chi è al governo. Sottolinea che la fiducia su società e lavoro si ferma 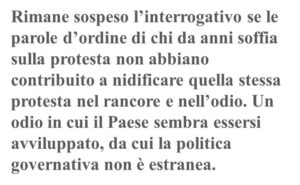 sulla soglia di un terzo del Pase, mentre avanza il “sovranismo” che l’istituto di ricerca definisce “psichico”, cioè “una subordinazione mentale alla ricerca di un sovrano a cui chiedere stabilità”. Rimane sospeso l’interrogativo se le parole d’ordine di chi da anni soffia sulla protesta non abbiano contribuito a nidificare quella stessa protesta nel rancore e nell’odio. Un odio in cui il Paese sembra essersi avviluppato, da cui la politica governativa non è estranea.
sulla soglia di un terzo del Pase, mentre avanza il “sovranismo” che l’istituto di ricerca definisce “psichico”, cioè “una subordinazione mentale alla ricerca di un sovrano a cui chiedere stabilità”. Rimane sospeso l’interrogativo se le parole d’ordine di chi da anni soffia sulla protesta non abbiano contribuito a nidificare quella stessa protesta nel rancore e nell’odio. Un odio in cui il Paese sembra essersi avviluppato, da cui la politica governativa non è estranea.
Se qualcuno nutre dubbi, può verificare l’escalation del ministro dell’Interno Matteo Salvini in tema di migranti attraverso una rapida rassegna dei suoi interventi immagazzinati da Google. Ad Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che ha definito razzista la politica della Lega, Salvini ha replicato con un tweet di questo tenore: “Esagero se dico che queste parole e questo atteggiamento mi fanno schifo”. Mesi fa, lo stesso Salvini con un altro tweet aveva denunciato la fuga di un immigrato malato di tubercolosi dall’ex hotel di Sandrigo nel Vicentino, trasformato in centro di accoglienza dei migranti. Parole allarmate che si prestavano a ipotizzare (ipotesi ripresa a stretto giro di posta dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti) presunti aumenti di casi di Tbc in Italia veicolati dagli immigrati. Parole che si chiudevano per catturare la “pancia” dei lettori con un commento più da agit-prop che da ministro dell’Interno: “Dicevano che eravamo cattivi, allarmisti, pericolosi…”. Un intervento comunque sufficiente a chiamare in causa indirettamente il ministro della Salute, Giulia Grillo (Movimento cinque stelle), che però scartava l’ipotesi di un allarme-tubercolosi, correlato alla presenza di migranti. “Se ci fosse stato il ministero e l’Istituto Superiore di Sanità lo avrebbero segnalato”.
Solo uno stop verbale alle invadenze di campo del ministro dell’Interno da parte dell’alleato grillino, che produce tanti, troppi malpancisti nel Movimento? O come probabile, il tentativo di riprendere autonomia di pensiero e agibilità politica sul terreno scottante dei migranti, egemonizzato da Salvini tra, al quali lo stesso Di Maio aveva lanciato… una ciambella di salvataggio a fine agosto, quando il leader leghista era stato indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso di potere nella vicenda della nave Diciotti. Nella circostanza, il ministro al Lavoro aveva difeso Salvini da una parte – “non deve dimettersi” – e assolto la politica del governo dall’altra – “noi abbiano sempre protetto chi scappa da una guerra” – sintetizzando l’azione di palazzo Chigi come solo e unicamente rivolta a tutelare “gli inte- ressi del nostro Paese”. Nel frattempo – a quattro mesi dal braccio di ferro con la nave Diciotti – il recente decreto Salvini toglie l’ossigeno ai centri d’accoglienza e per i migranti, anche per quanti in possesso del permesso di soggiorno, è cominciato l’esodo verso soluzioni d’emergenza al limite della sopravvivenza e di degrado per la dignità umana, in cui il rischio di morire – come è accaduto ai primi di dicembre al diciottenne Suruwa Jaiteh, vittima del rogo nella tendopoli di San Ferdinando nel Reggino – si accetta con ordinaria fatalismo per non impazzire.
Il fastidio anche beffardo – anticamera dell’odio – per il diverso, l’estraneo, l’immigrato, ha avuto di recente anche un altro conio politico da Salvini, promosso su tutte le reti televisive e radiofoniche: il reclutamento al rovescio dei “nemici” per la manifestazione leghista dello scorso 8 dicembre a Roma, denominata “Prima gli italiani”. Sui social sono apparse le foto di alcuni per-sonaggi invisi alla Lega, da Fabio Fazio a Mario Monti, a Laura Boldrini, a Roberto Saviano, Valeria Fedeli, Matteo Renzi, Gad Lerner, con il sottotitolo “lei (o lui) non ci sarà”. Una forma di esclusione brutale, ma non irrituale in politica, che ha dato l’impressione di un’autentica lista di proscrizione calata dall’alto per essere “applicata” dal basso. Versione, se si vuole, raffinata, ma non dissimile dalle invettive piene di acredini del profeta del “vaffa” Grillo verso giornalisti, manager d’industria, scienziati e politici. Sono soltanto parole… in libertà oppure no?
Salvini, ministro dell’Interno o di tutto?
Al quesito potrebbe rispondere il ministro al Viminale Matteo Salvini che il 4 dicembre con una velocità degna del migliore nativo digitale spedisce in rete i complimenti alle forze dell’ordine per un’operazione contro la mafia nige-riana. Come annota un attento osservatore del costume e della politica “non è il primo (e purtroppo non sarà l’ultimo) ministro dell’Interno ad operare i successi della macchina investigativa del Viminale nella lotta alla criminali-tà”. Ma, oltre ad avere l’indice più rapido sulla tastiera virtuale dello smar- tphone che la storia politica ricordi, è anche il più imprudente e scatena la rabbia del procuratore capo della Procura di Torino Armando Spataro, che in una nota ufficiale lo accusa di aver danneggiato le indagini, ancora in corso. La controreplica alza i toni dello scontro, con il ministro che giudica “inaccettabili le critiche” e invita Spataro (alla soglia della pensione) a ritirarsi dal lavoro. Passa sotto silenzio, invece, l’osservazione di merito (spetta al magistrato la responsabilità ultima dell’operazione giudiziaria), mentre scatta il biasimo per “gli attacchi gratuiti politici, da lasciare a chi si voglia candi- dare in politica”. Ancora parole in libertà? Sicuramente non la pensa così il Procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo che alla stampa detta una secca dichiarazione: “Quelle di Salvini sono parole sgradevoli e inaccettabili per tono e contenuto”. Sulla stessa linea si esprime il vicepresidente del Csm David Ermini che giudica il tono del ministro dell’Interno inaccettabile e lo ammonisce a non spettacolarizzare gli eventi a fini di propaganda politica. E in quegli stessi giorni Spataro ha chiosato un amaro commento, mettendo il dito nella piaga della deriva presa dalla società italiana: “agli sfottò sorrido, ma mi preoccupa che certi atteggiamenti paghino.”
Fino a quando pagheranno gli atteggiamenti che tanto preoccupano Armando Spataro? Dal sorriso compiaciuto che mostra nei selfie il ministro dell’Inter no Salvini la fine dell’idillio con l’elettorato sembrerebbe piuttosto remota. I sondaggi premiano la Lega e il suo leader che si muove con l’agilità di un provetto surfista sulle onde della politica. E non solo domestica. L’11 dicembre, in visita in Israele, il ministro posta un tweet e alcune foto scattate sull’elicottero in volo al confine con il Libano. Il senso e il tono sono inequivocabili, e producono immediate fibrillazioni alla Farnesina e al ministero della Difesa. Twitta Salvini: “Chi vuole la pace, sostiene il diritto all’esistenza e alla sicu- rezza di Israele. Sono stato al confine col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione. Onu e Ue facciano la loro parte”. È una gaffe viziata da egocentrismo solo in apparenza. Dietro esiste il preciso calcolo politico di accreditare il sovranismo nazionale presso la corte di Netanyahu, premier di destra d’Israele, di cui la polizia chiede proprio in quei giorni l’incriminazione per corruzione. La terza per lo stesso reato: un collezionista insieme alla moglie. Vale dunque la pena sacrificare gli interessi collettivi per un consenso personale che si po- trebbe rivelare di qui a qualche mese effimero?
Se Salvini non se lo chiede, è probabile qualche domanda se la siano invece posta chi rischia la vita in quella striscia di terra, cioè i militari della missione Unifil (promossa nel 2006 dall’Italia dell’allora presidente del Consiglio Prodi con D’Alema ministro degli Esteri), da alcuni mesi al comando del generale italiano Stefano Del Col. A quei militari dev’essere apparso un gesto totalmente slegato dalla loro sicurezza e dalla situazione che regna lungo la “Linea blu” che fa da cuscinetto neutro tra Israele e il sud del Libano. Eppure, dopo l’incontro tra il presidente palestinese Abu Mazen e Conte, non era certo arbitrario attendersi dal Viminale, nell’interesse del Paese, un comportamento più misurato e sobrio, distante dalla spettacolarizzazione dei social, in piena sintonia con la nostra politica estera e la presenza di un contingente italiano in prima linea su quel caldo fronte. Ciò che nei giorni precedenti era ritenuto auspicabile per superare la crisi sui tunnel scavati da Hezbollah in territorio israeliano.
Come se ne uscirà?
Nel numero del 16 dicembre de La Voce e il Tempo, la giurista Annamaria Poggi ha dedicato un corposo intervento ai cambiamenti avvenuti nelle società occidentali, in cui prevalgono populismi che minacciano dichiaratamente la democrazia, pur promettendo il bene comune. Il fine è dunque lo stesso della democrazia, ma i mezzi con cui raggiungerlo sono diversi, mentre quelli a quali si è finora affidata la democrazia sono in crisi. L’autrice sostiene che le risposte su come fronteggiare questi fenomeni per ora non ci sono. “Al populismo (ciò che il popolo vuole) si contrappone la competenza (ciò che il popolo dovrebbe sapere); alla democrazia del web si oppone la democrazia fisica; alla democrazia diretta quella rappresentativa e via dicendo…” Ma le risposte vanno cercate alacremente. E il pensiero, reso fruibile dalla forza della parola, rimane, per quanto antica, la forma più moderna per affinare la democrazia e non farsi sedurre da scorciatoie politiche che potrebbero rivelarsi, come in passato, esiziali per la convivenza civile. Il pensiero inteso come nastro trasportatore di valori per non cadere nella trappola della semplificazione fuorviante, dell’intolleranza verso la complessità del mondo che esige sì spiegazioni semplici alla portata di tutti, fase ultima però di una serie di elaborazioni che diano la parola a tutti per riflettere insieme e per suscitare mediazione democratiche che rifuggano da un sì o un no urlato nelle piazze. Attorno a queste due sillabe si è già consumato un tragico passato, per ripro- porle con stucchevole cinismo.
I valori sono quelli “politici” e quelli “morali” connaturati, per citare un grande maestro del passato, Norberto Bobbio, all’impegno civile.
Posted on: 2019/01/09, by : admin



